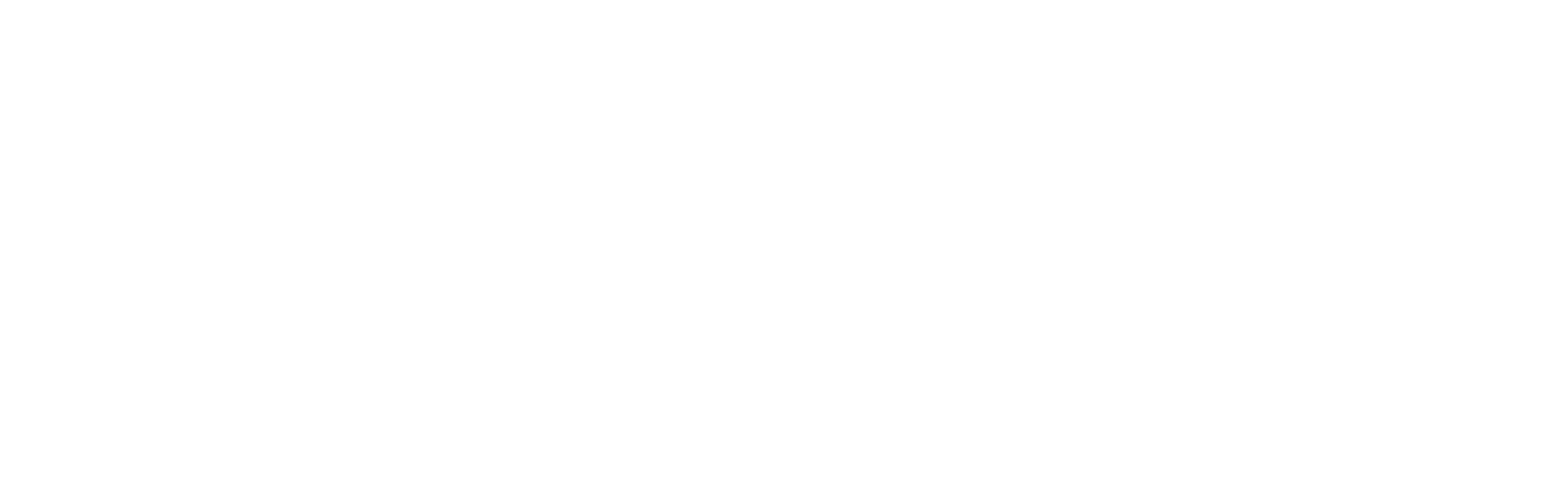Caso Labita c. Italia, la lezione di giurisprudenza della CEDU all’Italia dimenticata dai giudici italiani
14 Settembre 2018 | Diritto europeo, Revocazione
Il caso Labita rappresenta una delle sentenze più importanti in tema di applicazione delle misure di prevenzione e loro conformità ai principi sovranazionali e costituzionali. Pur ritenendo, la Corte EDU, la compatibilità del sistema normativo che disciplina le misure di prevenzione personali e patrimoniali con i principi della Convenzione, ha condannato la Repubblica Italiana per l’ingiusta applicazione nel caso di specie della misura di prevenzione personale. A seguito della pronuncia della corte il signor Benedetto Labita ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria in Italia per la revoca della misura allo stesso applicata. Soltanto a seguito della sentenza della Corte Cost. 113 del 2011, la Corte di Cassazione, nel frattempo adita, ha riconosciuto il diritto del medesimo a vedersi revocata, con effetti ex tunc, la misura personale e patrimoniale.
La sentenza Labita c/Italia costituisce nel panorama giurisprudenziale italiano ed europeo il più importante approdo in materia di “diritto di prevenzione”. Si tratta, secondo l’avvocato Baldassare Lauria che ha difeso Labita Benedetto, del primo caso di revisione cosiddetta “europea” pronunciata dalle corti italiane. In essa si riconosce l’incompatibilità ontologica tra la pronuncia assolutoria, maturata nell’ambito del processo penale che vedeva Labita imputato per associazione mafiosa, e la misura di prevenzione applicatagli, che invece lo riteneva appartenente alla consorteria mafiosa.
La “lezione di giurisprudenza” della Corte EDU nel caso Labita c. Italia, dopo qualche timida applicazione (caso Caruso), è stata poi disattesa dalle corti italiane, per le quali il giudicato assolutorio del proposto per la misura antimafia è del tutto irrilevante, e ciò sull’altare di una malintesa autonomia valutativa dei giudici della prevenzione, rispetto a quelli penali, che di fatto consuma un’evidente violazione del principio ne bis in idem.
I FATTI
Labita, dopo l’arresto avvenuto il 21 aprile 1992, viene sottoposto a custodia cautelare presso il carcere Ucciardone di Palermo, dove rimane chiuso in una cella di isolamento per 35 giorni. Il 6 maggio dello stesso anno richiede al tribunale di Trapani la remissione in libertà, ma la richiesta viene respinta. Il 20 luglio 1992 è trasferito al Carcere di Pianosa, dove rimane fino al 29 gennaio 1993. Viene sottoposto al regime del carcere duro previsto dall’art. 41-bis ordinamento penitenziario. Successivamente viene trasferito in altre carceri in base al luogo di svolgimento del processo. Il 12 novembre 1994 viene assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”. Il 14 dicembre 1995 viene confermato il proscioglimento dalla Corte d’Appello di Palermo. Dopo l’assoluzione viene sottoposto a misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e cancellato dalle liste elettorali. Benedetto Labita è rimasto in carcere per due anni e sette mesi.
Tra il luglio e il settembre 1992, denuncia di aver subito, nel carcere di Pianosa, maltrattamenti da parte degli agenti di custodia. In particolare egli dichiara di essere stato vittima di numerose violenze, umiliazioni, vessazioni, intimidazioni e altre forme di tortura sia fisiche che psicologiche: “Sarebbe stato sovente schiaffeggiato e percosso, sarebbe stato colpito alle dita, alle ginocchia e ai testicoli. Avrebbe dovuto subire ispezioni corporali durante la doccia e sarebbe rimasto ammanettato durante visite mediche. Le sue proteste erano inutili, addirittura controproducenti: una volta, avendo protestato perché gli agenti di custodia gli avevano strappato i vestiti, sarebbe stato minacciato, insultato e percosso da uno di essi. La sua protesi dentaria e i suoi occhiali sarebbero stati danneggiati e gli sarebbe stata rifiutata la possibilità di farli riparare, circostanze attestate dai referti medici. Sulla base di questi fatti, viene aperta un’inchiesta penale dalle autorità italiane. Labita rilascia le sue dichiarazioni nel corso dell’udienza del 2 ottobre 1993, di fronte al giudice delle indagini preliminari di Trapani e il 5 gennaio 1994 davanti ai carabinieri. Il giudice informa la competente procura, quella di Livorno, delle affermazioni rilasciate da Labita nel corso dell’udienza preliminare, per compiere le opportune indagini al riguardo. Dopo il 5 gennaio 1994, trascorrono ben quattordici mesi prima che il soggetto sia convocato per l’identificazione dei responsabili. L’unica attività che dal fascicolo risulta compiuta durante l’intervallo di tempo è l’acquisizione soltanto di fotocopie delle fotografie degli agenti di custodia che avevano prestato servizio a Pianosa nei mesi indicati da Labita. Egli non è in grado di riconoscere gli agenti dalle fotocopie mostrategli. Nonostante sostenga, per una seconda volta, il 9 marzo 1995, la capacità di riconoscere i responsabili dei maltrattamenti subiti, purché avesse potuto vederli di persona, non è stata accolta la sua richiesta. Il 18 marzo 1995 il pubblico ministero ottiene l’archiviazione del caso non per infondatezza ma perché rimasti ignoti gli autori del reato. Il 10 aprile 1994 Labita presenta ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il 29 settembre 1999 la Commissione, all’unanimità, dichiara ricevibile il ricorso di Labita e trasmette la questione alla Corte per la sentenza definitiva.
L’ITALIA CONDANNATA PER L’INADEGUATEZZA DELLE INDAGINI SULLE DENUNCIATE TORTURE
Il 6 aprile 2000 arriva il verdetto. La Corte, per nove voti contro otto, ha ritenuto che non ci sia stata violazione dell’art. 3 per quanto riguarda le accuse di maltrattamenti ma, all’unanimità, ha ritenuto violato lo stesso articolo 3 della CEDU per il mancato svolgimento di indagini ufficiali efficaci sulle denunce effettuate dal Labita alle autorità italiane. La sentenza è, quindi, contraddittoria: da una parte l’Italia viene assolta in quanto il ricorrente avrebbe denunciato con troppo ritardo i maltrattamenti subiti, dall’altra viene condannata perché le indagini svolte dalle autorità dello Stato non sono state approfondite ed effettive. Per l’organo di Strasburgo è importante, infatti, affinché il divieto di cui all’art. 3 non sia inefficace, che si effettui “un’indagine ufficiale”, la quale “deve poter condurre all’identificazione e alla punizione dei colpevoli”. Dalla mancanza di una inchiesta ufficiale effettiva sui presunti maltrattamenti consegue, per i nove giudici, l’assenza delle prove, pertanto l’Italia deve essere condannata non per le violenze denunciate, per le quali non si hanno, appunto, riscontri sufficienti, ma per le procedure inefficaci seguite dalle autorità italiane. Viceversa, la minoranza della Corte (otto giudici) ritiene che proprio l’indagine inefficace, nonché i rapporti del giudice di sorveglianza di Livorno (5 settembre 1992) e del presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze (12 dicembre 1996) sulla situazione precaria del carcere di Pianosa, confermino le denunce effettuate. La Corte, quindi, si è spaccata a metà nel giudizio finale ed ha salvato per poco il governo italiano da una delle più gravi condanne, quella per tortura e trattamenti disumani e degradanti di cui all’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la stessa sentenza la CEDU ha condannato l’Italia per l’applicazione erronea della misura di prevenzione personale applicata al LABITA nonostante lo stesso fosse stato assolto dal reato di associazione mafiosa perché il fatto non sussiste.